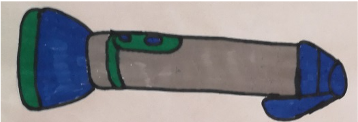Oltre l'Orizzonte
"È grave essere diversi?"
"È grave sforzarsi di essere uguali: provoca nevrosi, psicosi, paranoie. È grave voler essere uguali, perché questo significa forzare la natura, significa andare contro le leggi di Dio che, in tutti i boschi e le foreste del mondo non ha creato una sola foglia identica a un'altra."
- Paulo Coelho, Veronica decide di Morire -
Le pratiche dialogiche
Le esperienze dialogiche e la promozione
di narrazioni condivise nelle esperienze psicotiche
Giuseppe Tibaldi
Direttore Area NordDSM di Modena,
membro del Direttivo SIEP e trainer “Dialogo Aperto”
Le “Pratiche Dialogiche” sono nate dal “Dialogo Aperto”, come approccio per aiutare le persone e i loro famigliari a sentirsi ascoltate, rispettate e valorizzate.
A partire dal 1984, presso l'ospedale Keropudas di Tornio, in Finlandia, il personale già formato in terapia famigliare decise di cambiare le modalità di trattamento dei pazienti. A seguito del lavoro svolto da YrjöAlanen, modificarono la loro risposta alle crisi acute istituendo una riunione di gruppo, riunendo insieme alla persona interessata, la sua famiglia, altre persone amiche e tutti i professionisti coinvolti, prima di prendere qualsiasi decisione riguardo a un eventuale ricovero.
Questa fu la nascita di una nuova pratica aperta che si sviluppò, insieme a una continua innovazione clinica, modifiche organizzative e ricerche, in ciò che ora va sotto il nome di “Dialogo Aperto”, descritto per la prima volta in quanto tale nel 1995.
Il concetto di “apertura” nel Dialogo Aperto si riferisce alla trasparenza dei processi di programmazione e decisionali, che hanno luogo in presenza di tutti gli interessati. Ciò non significa che i parenti siano obbligati ad esprimersi su questioni che i terapeuti pensano che si debbano affrontare con franchezza. Sin dall'inizio, questo approccio di rete venne applicato a tutte le situazioni di trattamento terapeutico.Nell'arco di un decennio, la tradizionale struttura ospedaliera dell’area finlandese di Tornio fu trasformata in un sistema psichiatrico complesso, con piena continuità della cura sia sul territorio che in ambito ambulatoriale e ospedaliero.
La pratica del Dialogo Aperto ha quindi due caratteristiche fondamentali:
1) un sistema di cura integrata basato sulla comunità locale che coinvolge i famigliari e le reti sociali sin dal primo momento in cui è richiesto un aiuto;
2) una “Pratica Dialogica”, o una forma definita di incontro terapeutico all'interno della “riunione di cura” (“treatment meeting”).
Le pratiche dialogiche
La riunione di cura costituisce il contesto terapeutico chiave del Dialogo Aperto, e unifica i professionisti e la rete in un insieme collaborativo. Così la Pratica Dialogica viene incorporata in un più ampio servizio psichiatrico che condivide i suoi spazi, perché è essenziale disporre di entrambi gli aspetti.
L'approccio del Dialogo Aperto è di tipo integrativo, al quale si possono aggiungere altre modalità terapeutiche, adattandole alle necessità della persona e dei famigliari, come parte di uno “schema di cura” ad ampio spettro e flessibile. Sette sono i principi base nel Dialogo Aperto, che sono le linee guida proposte originariamente dall'équipe finlandese. Eccoli:
- Aiuto immediato (capacità dei professionisti di rispondere nell’arco di 24/72 ore alle nuove richieste di aiuto).
- Prospettiva di rete sociale (coinvolgimento di tutti i soggetti significativi della rete personale e micro-sociale).
- Flessibilità e mobilità (la frequenza e la sede degli incontri viene decisa insieme, con una preferenza per gli incontri a domicilio).
- Responsabilità (chi riceve la richiesta di aiuto si incarica di organizzare il primo incontro, senza deleghe ad altri servizi).
- Continuità psicologica (chi partecipa agli incontri mantiene la propria disponibilità fino al termine del percorso di cura).
- Tolleranza dell’incertezza (tutte le decisioni vengono concordate, anche in situazioni di instabilità).
- Dialogo e polifonia (tutte le voci devono essere ascoltate ed il ruolo dei professionisti è di favorire il dialogo).
Testo di riferimento: Arnkil TE &Seikkula J “Metodi dialogici nel lavoro di rete” Erickson, Trento, 2013

Disegno di Roberto
Le pratiche dialogiche una esperienza
Veronica
Un anno fa, il 9 settembre, lasciavo il piccolo reparto dell’ospedale che mi aveva ospitato per alcuni giorni. Dopo un breve dibattito sul fatto che io fossi pronta a tornare a casa, a riprendere l’attività lavorativa così velocemente, il personale medico aveva optato per le dimissioni. Ricordo la sensazione di libertà provata nell’istante in cui sono uscita all’esterno dell’edificio, ma anche una certa paura, molta insicurezza e la necessità nel contempo di tornare a fare ordine nella mia mente, come nella mia vita.
Ma cosa mi era accaduto? Perché una persona considerata equilibrata e forte si era ritrovata ad affrontare un ricovero in psichiatria?
Sono molti gli elementi intervenuti nel creare le condizioni, le premesse perché il disagio emergesse, perché arrivasse la crisi. La guarigione passa necessariamente dalla consapevolezza e dalla comprensione delle cause. Sicuramente un primo elemento di fragilità era rintracciabile in un’infanzia poco serena all’interno di una famiglia in cui era presente uno zio etilista e violento che aveva riempito le giornate di ansia e paura per un periodo di almeno 15 anni. Si trattava di una persona intelligente, a tratti brillante, che però aveva usato male le sue doti, divenendo causa di grande dolore in chi gli stava attorno.
Si aggiunga a questo che, essendo stata considerata fin da piccola una bambina portata per lo studio e dalle buone capacità, dentro di me era sorto il dubbio che potessi anche io un giorno agire in modo negativo ed ho da subito, forse neppure adolescente, costruito un sistema di controllo, di vigilanza, che mi impedisse di compiere gesti spiacevoli per chi mi era accanto. Sicuramente quindi una prima ragione di ansia nasceva dal clima poco sereno attorno a me, ma era acuita dalla reazione che il contesto aveva causato dentro di me.
Un altro aspetto importante è legato a quello che rappresentavo nell’immaginario dei miei familiari. Ero la figura che avrebbe riscattato tutti, che avrebbe avuto sicuramente successo nella vita.
Amavo davvero studiare, non era un’imposizione, ma le aspettative di tutti hanno caricato di un enorme peso anche quello che doveva essere l’espressione di una passione. Non potevo fallire e deludere tutti. Mi sono quindi chiusa in me stessa, ho limitato le relazioni con gli altri e mi sono dedicata anima e corpo allo studio.
La mia crescita sul piano cognitivo non è stata affiancata da una, altrettanto attenta, cura della socialità.
Quando ho conosciuto il mio attuale compagno, ero ormai all’università, imprigionata nel personaggio della figlia perfetta e studentessa perfetta. Come potevo non essere anche la fidanzata perfetta, soprattutto quando avevo al mio fianco un ragazzo che consideravo degno di grande stima e rispetto. Anche in tale rapporto mi sono adeguata alle aspettative, che non sempre rispondevano ai miei veri desideri, in un tentativo di continua captatio benevolentiae. Così, quando abbiamo affrontato il quesito sollevatosi di fronte ad una gravidanza indesiderata, ecco che la mia risposta non poteva che essere allineata a quella del mio uomo.
Nel segreto più assoluto, sono ricorsa ad una IVG, vivendo poi enormi sensi di colpa legati ad una educazione fortemente cattolica, in cui il rispetto per la vita è sostanziale. E questa mia sofferenza non ha avuto sfogo, non è stata condivisa e quindi è rimasta irrisolta dentro di me.
Poco per volta del mio vero io, dei miei sogni, delle mie ambizioni non era rimasto più niente. Ero ciò che gli altri volevano fossi: gentile, disponibile, accondiscendente, nella vita privata, ma
Le pratiche dialogiche una esperienza
anche sul lavoro. Ma il mio essere più profondo non ha più retto. Il carico da portare era troppo pesante
E così la comparsa, a tratti, di ansia e poi progressivamente un senso di rabbia crescente, esplosivo, che riuscivo a contenere con difficoltà. Insoddisfazione, desiderio di fuggire da ogni costrizione da una parte e la vita di tutti giorni dall’altra, in uno scontro titanico che mi ha privato di tutte le forze.
E poi uno strano fattore scatenante, l’incontro-scontro con una famiglia del palazzo dove abitavo: due bambini a cui tutto era concesso, forse quella libertà che sentivo di non avere mai avuto e nel contempo la totale mancanza del rispetto delle regole, cosa per me insopportabile visto che avevo fatto proprio del rigore un mio baluardo.
Avevo già allontanato i miei genitori a seguito di alcuni litigi. Il mio compagno non sembrava percepire quelli che vivevo come problemi al pari di me e quindi mi sono sentita sola, sola in un mondo interiore ed esterno che non volevo più accettare. A questo punto, la crisi, la reazione estrema, l’urlo di dolore. Come far capire agli altri cosa veramente sentivo, se io stessa ero il primo impedimento, se continuavo ad evitare ogni motivo di scontro a discapito della mia felicità.
Sono fuggita dal mondo reale e ne ho inventato uno mio. Inizialmente era innocuo, era fatto dai miei pensieri trasformati in dialoghi con vicini, conoscenti. Il vuoto intorno a me si era riempito di mille conversazioni che soddisfacevano il mio bisogno di confronto, ma anche di supporto. Poco per volta però avevo perso coscienza del fatto che provenissero da me, dandogli vita propria, facendoli diventare reali. Ho cominciato a vivere due vite parallele, quella vera in cui ancora riuscivo ad interagire quasi normalmente e quella fittizia che via via diventava predominante e assumeva connotazioni fantastiche: riuscivo a leggere il pensiero delle persone ed a dialogare con figure ultraterrene.
Qualcosa intanto stava cambiando. Quello che inizialmente era un conforto, una forma di appagamento rispetto ad una vita relazionale vera insoddisfacente, stava diventando un’ossessione. Le voci erano sempre più presenti e cominciavano a trarre spunto dalle mie paure e sensi di colpa, facendosi minacciose. Il mondo parallelo si è popolato di persone malvagie, cospiratrici, di demoni. Ogni parola detta nascondeva un inganno od una vessazione ed io sprofondavo sempre di più nell’angoscia.
Questo mondo mi stava fagocitando e riuscivo ad interagire ogni giorno di meno con le persone vere. La tenue consapevolezza che mi aveva portato a dubitare delle mie percezioni, tanto da indurmi a chiedere di essere portata in pronto soccorso, stava svanendo.
Ho allontanato il mio compagno, persino l’amato gatto, i miei genitori fino a fuggire e vagare per la città, nella convinzione di essere inseguita da esseri malvagi e di dover combattere per la mia vita. Vedevo e sentivo quanto accadeva nella realtà, ma era distorto, trasformato, come un raggio di luce che viene diffranto penetrando nell’acqua.
Anche il personale sanitario, che mi ha condotto in ospedale, dopo una notte trascorsa seduta al centro di una piazza cittadina, era costituito da cospiratori. Tutti volevano il mio male, la mia dannazione eterna.
Sono giunta in ospedale in queste terribili condizioni, in preda di continui incubi ed allucinazioni non solo più uditive, ma in parte anche visive. Ricordo solo che temevo che ogni farmaco fosse un veleno, che i sedativi mi facessero
Le pratiche dialogiche una esperienza
dormire per anni, che questa prigionia, questo inferno non sarebbe mai finito. Schiacciata dai sensi di colpa, sapevo di poter essere salvata solo da qualcuno che avesse riconosciuto la mia innocenza. Ero il carnefice di me stessa, in attesa di un perdono che potesse ridonarmi la speranza.
Le riflessioni sulle cause e la consapevolezza dell’accaduto sono frutto del lungo percorso iniziato proprio con il ricovero.
Ovviamente nei primi giorni un ruolo fondamentale è stato svolto dai farmaci. Bisognava infatti che fossi in grado di comunicare ma, appena si è aperto uno spiraglio, una via, lo psichiatra che aveva preso in carico il mio caso, ha iniziato una serie di colloqui. Come primo obiettivo, ha proprio cercato di rendermi consapevole dell’accaduto con tutti gli strumenti a disposizione, dal dialogo, al disegno, allo schema. Ha quindi cercato di comprendere quale fosse il mio contesto familiare, al fine di coinvolgere nel modo più opportuno gli altri soggetti.
La guarigione deve infatti passare anche dalla comprensione dell’accaduto da parte di chi ci circonda. Uscita dall’ospedale sono quindi iniziati i colloqui di gruppo con i miei genitori ed il mio compagno.
La fase più difficile è durata un paio di mesi. Sono infatti tornata subito a lavoro, perché il contatto con la vita reale avrebbe sicuramente avuto una funzione curativa. Intanto però continuavo a prendere i farmaci, sebbene con dosaggi progressivamente ridotti; e continuavano i colloqui di gruppo, quelli solo con il medico, ma anche la lettura di testi ad hoc e soprattutto un continuo lavoro di analisi ed introspezione, i cui frutti venivano elaborati in forma scritta e fatti pervenire al medico. Rendere partecipi i familiari non sempre è facile. Richiede la volontà di mettersi in gioco, di condividere esperienze positive e negative, di dire quello che spesso non si osa dire. Poco per volta, grazie alla mediazione degli specialisti, le tensioni si sono progressivamente sciolte ed è stato quindi possibile confrontarsi sulle criticità. Dopo circa sei mesi ero pronta a sospendere il farmaco.
Superata la paura che le voci tornassero, anche perché ora ne conoscevo la natura, mi sono resa conto che potevo farcela, che avrei potuto riprendere in mano la mia vita.
Ma gli ostacoli non finiscono mai e quando sei debole, li vedi ancora come insormontabili. Dopo una breve fase di euforia, mi sono sentita nuovamente svuotata e non vedevo più un obiettivo da raggiungere, qualcosa che mi desse la spinta propulsiva. Mi sentivo inoltre messa a nudo, esposta. Le fragilità che avevo tenuto ben nascoste ora erano lì, davanti a tutti. La mia vecchia immagine era distrutta e bisognava costruire una persona nuova.
Ma in quel momento non mi sono arresa ed ho cominciato a modificare alcuni di quei comportamenti che mi avevano portato a quel profondo stato di stress che aveva quasi distrutto la mia vita. Ho cominciato a dedicare maggior tempo al riposo ed alla cura della mia persona.
Ho chiarito ulteriori aspetti relazionali con i miei familiari e con il mio compagno, ho ridotto il carico di lavoro a cui mi sottoponevo ed ho cominciato a coltivare una mia vecchia passione che era l’attività fisica riprendendo ad andare in palestra. L’insieme di questi elementi mi ha consentito di allentare la tensione, di tornare a respirare, di immaginare nuovamente un futuro. Ho cominciato a frequentare delle persone ad avere dialoghi veri, nella vita reale e non in universi allucinati.Adesso mi sento di nuovo più forte, sicura di me. I ricordi del periodo di crisi che erano vividi fino ad alcuni mesi fa, sempre presenti nella mia mente, quali volessero
Le pratiche dialogiche una esperienza
essere un promemoria, un monito dell’accaduto, cominciano ad affievolirsi. Finita la tempesta, dopo la disperazione davanti alle macerie, si può ritrovare l’entusiasmo nel ricostruire.
Ed oggi sono qui, a raccontare il mio percorso di guarigione, la mia storia, per dare speranza a chi ancora questo cammino non lo ha concluso.
Gli ostacoli sono tanti, il percorso è lungo, ma si può andare oltre. Bisogna maturare la convinzione che anche le problematiche psichiche e non solo quelle fisiche possono essere momentanee, che i farmaci non devono accompagnare necessariamente un’intera esistenza, ma che si può trovare un nuovo equilibrio, inizialmente appoggiandosi a chi è attorno a noi, per poi trovare la forza dentro se stessi, a tempo debito.
Giuseppe
Ho incontrato Veronica nel reparto di psichiatria, al rientro dalle mie vacanze estive. Era arrivata in reparto da un paio di giorni ed ho saputo, dai colleghi che era al suo primo ricovero. Il mio percorso di training dialogico in Italia stava per concludersi, mentre quello triennale a Londra era arrivato a metà.
Quando ho proposto a Veronica un incontro, in reparto, con i genitori ed il fidanzato, mi ha detto che era meglio rimandarlo, perché la sua crisi aveva creato una situazione di conflitto tra il padre ed il fidanzato ed era meglio aspettare. Ho rispettato questa sua richiesta e le ho offerto alcune, lunghe, occasioni di dialogo a due, nei giorni immediatamente successivi.
È stata dimessa dal reparto prima del previsto, meno di due settimane dall’ammissione, a pochi giorni dall’apertura dell’anno scolastico. Anche se non era sicura di farcela, aveva espresso il desiderio di provare a riprendere subito la sua attività come insegnante.
Subito dopo la dimissione, è avvenuto il primo incontro con lei, i genitori ed il fidanzato. Era venerdì pomeriggio e il weekend che incombeva sembrava pieno di nubi minacciose. Il padre temeva un immediato rientro in ospedale. Sono stati presi accordi davvero inusuali, per rispettare la richiesta di Veronica di poter riposare tranquilla, nella sua stanza da letto: è stata recuperata la porta della cucina, che era finita in cantina, per limitare i movimenti notturni del gatto; il padre (con cui Veronica non era a proprio agio) si sarebbe presentato a casa sua alle 10 di sera, per dormire in cucina con il gatto, e se ne sarebbe andato alle 7 del mattino; il fidanzato si sarebbe presentato verso le 10 del mattino, per andarsene nel tardo pomeriggio.
Io ho dato la mia mail a Veronica e le ho chiesto di tenermi aggiornato, durante il weekend. La terapia farmacologica non è stata modificata.
Ci siamo rivisti il martedì successivo e già sapevo, grazie alle mail, che le nubi più minacciose si erano allontanate. Il canale delle mail è stato molto prezioso ed ha rappresentato la forma di prosecuzione dei colloqui a due con cui era iniziato il nostro dialogo in reparto. È grazie a questo canale che ho potuto chiedere a Veronica il suo racconto sul percorso fatto insieme, dopo aver ricevuto molto altro (compresa una descrizione mozzafiato della graduale progressione dei vissuti psicotici, prima del ricovero). È grazie a questo canale che continuo ad ottenere qualche aggiornamento, come pure il consenso alla pubblicazione del suo racconto. Nel frattempo, infatti, mi sono trasferito a Carpi, in Emilia Romagna.
Durante la prima fase dopo la dimissione, Veronica ha utilizzato il libro di Ron Coleman “Lavorare con le voci”, che le ho fornito, per fare un’analisi dettagliata delle sue voci. Ha letto anche altri materiali, provenienti dal Movimento degli Uditori di Voci.
Le pratiche dialogiche una esperienza
Gli incontri con i genitori, il fidanzato (ed il gatto) si sono svolti a casa di Veronica. Sono stati dodici, in totale, a distanza più ravvicinata, inizialmente, e poi sempre più distanziati. L’ultimo è avvenuto alla fine di agosto, circa 12 mesi dopo la dimissione dall’Ospedale.
La mia esperienza di questo viaggio ruota intorno a tre parole chiave, del vocabolario dialogico:
1.Il “need-adaptedapproach” che ha caratterizzato l’inizio del percorso con Veronica e la sua famiglia. La sua richiesta di rimandare l’avvio degli incontri con la sua rete andava rispettata, ma non poteva non essere accolta, subito, la sua esigenza di dare significato a quanto le era accaduto. Così pure, andava rispettato il suo desiderio di riprendere l’attività scolastica, anche se la situazione, personale e relazionale, era ancora instabile. Infine, è stata mantenuta la disponibilità ad uno spazio individuale di elaborazione, che correva parallelo con lo spazio condiviso con i genitori, il fidanzato ed il mio partner. Non li ho mai avvertiti come spazi in conflitto.
2.La “tolleranza dell’incertezza”: l’ho provata subito, quando ho proposto il percorso dialogico, che Veronica mi ha proposto di rimandare. L’ho provata quando i miei colleghi hanno dimesso Veronica a mia insaputa, prima del termine concordato: non sapevo se il viaggio iniziato in reparto sarebbe proseguito. L’ho provata durante il primo incontro, di fronte alle nubi minacciose all’orizzonte del weekend. L’offerta a Veronica della mia mail, che – a posteriori – si è rivelata preziosissima, è stata la mia strategia di gestione dell’incertezza, così intensa, in quell’incontro. L’incertezza non si è mai dissolta del tutto: ogni tanto fa capolino, forse in rapporto alla distanza geografica che si è venuta a creare. Ma basta una mail, per tenerla a bada.
3.La “fiducia”. Non avevo mai condiviso alcun percorso terapeutico con il mio partner, Ugo, anche se lavoravamo nello stesso Dipartimento di Salute Mentale da moltissimi anni. Anche lui stava completando il training Open Dialogue organizzato in Italia. La nostra partecipazione al percorso di questa famiglia è avvenuta senza alcuna difficoltà; credo che questo abbia, in parte, sorpreso anche noi stessi. I dialoghi riflessivi, sul divano della cucina di Veronica, hanno avuto – spesso – toni di leggerezza e profondità, oltre che numerosi accenni alle nostre vite personali. La fiducia era palpabile anche nei rapporti con Veronica e la sua rete. L’evoluzione positiva, dopo le turbolenze iniziali, ha sicuramente dato un notevole contributo.
È passato quasi un anno, dall’ultimo incontro a casa di Veronica. Ho ricevuto tre mail, nel frattempo. Il nostro viaggio di scoperta dell’ignoto continua, anche se su sentieri apparentemente paralleli.